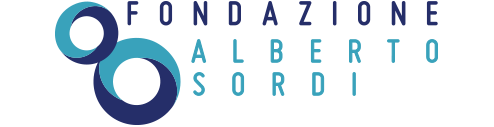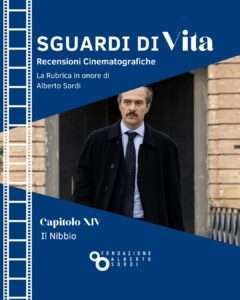L’11 aprile, a Piacenza, si è concluso il Meeting delle Professioni di Cura 2025, intitolato “Non corpi, persone – Far luce sul senso della cura”. In questa cornice, la Fondazione Alberto Sordi ha promosso e organizzato il workshop “Connessioni tra persone: generazioni a confronto e territori in dialogo”.
Sono state giornate intense di riflessione sul significato profondo dello “stare accanto” nella fragilità, nella malattia e nell’accompagnamento alla fine della vita. Un’occasione preziosa di condivisione, confronto e stimolo a prendersi cura gli uni degli altri, con rinnovato impegno e consapevolezza.
Di seguito, il testo integrale dell’intervento di Laura Campanozzi, ricercatrice in bioetica presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma.
A volte, per scorgere ciò che abbiamo davanti agli occhi, non basta guardare meglio: serve un nuovo apprendistato dello sguardo, capace di scardinare abitudini percettive e stereotipi radicati. È ciò che accade quando impariamo a vedere l’altro in modo diverso, non riducendolo a ciò che rappresenta o a ciò che produce, ma riconoscendone la profondità e la presenza. Quando si parla di relazioni tra generazioni, soprattutto in un tempo come il nostro in cui la velocità e l’efficienza tendono a oscurare il valore della lentezza e della memoria, questo cambio di visione è indispensabile. Servono davvero occhi nuovi, per accorgerci della ricchezza spesso silenziosa dell’età anziana.
Simone de Beauvoir, nel suo importante saggio La vecchiaia ci mette in guardia dal rischio di una società che considera gli anziani come “altri da sé”, separandoli dalla continuità dell’esperienza umana. In realtà, ciò che ci lega a chi ha più anni non è una distanza da colmare, ma una profonda prossimità da riconoscere. Gli anziani non sono il passato da archiviare, ma testimoni dell’umano, e ogni incontro con loro può diventare occasione per riscoprire qualcosa di essenziale.
Tuttavia, parlare di “scambio intergenerazionale” può risultare fuorviante. Lo scambio, infatti, presuppone un dare e ricevere misurabile, talvolta quasi contrattuale. Ma la relazione tra giovani e anziani non si esaurisce in uno scambio di informazioni o di competenze: essa può diventare dialogo. Il dialogo, secondo Karl Jaspers, non è semplice comunicazione, ma apertura radicale all’altro nella sua unicità irriducibile. Nel suo La fede filosofica di fronte alla rivelazione (1962), l’autore insiste sul fatto che la comunicazione autentica (o comunicazione esistenziale) accade nello spazio della libertà, quando si è disposti a incontrare l’altro non come funzione o categoria, ma come persona. In questo senso, il dialogo non ha come scopo un utile, ma una trasformazione reciproca, che avviene attraverso l’incontro profondo tra due interiorità.
Così, l’unicità diventa la chiave: non come semplice differenza, ma come quel nucleo irripetibile che fa di ogni vita un universo intero. Ogni anziano – come ogni giovane – custodisce un modo singolare di essere al mondo, una trama di vita che non può essere ridotta a una funzione sociale. Vederlo con occhi nuovi significa rinunciare a ogni generalizzazione, e lasciarsi toccare dalla sua storia concreta, dalla sua voce, dal suo tempo. È qui che il dialogo intergenerazionale rivela tutta la sua forza trasformativa: non per insegnare o ricevere qualcosa in astratto, ma per abitare insieme una relazione che arricchisce entrambi, in modo imprevedibile e profondo.
Per i giovani, questo significa uscire da un orizzonte spesso dominato dall’omologazione e dalla fretta, per accedere a forme più lente e profonde di apprendimento: la capacità di ascolto, il rispetto del tempo dell’altro, la pazienza della narrazione, la consapevolezza della finitudine e della memoria. Per gli anziani, significa sentirsi riconosciuti, riattivati, partecipi di un tessuto sociale che non li esclude, ma li accoglie come presenza viva.
Perché l’unicità, quando viene davvero accolta, rompe i copioni. Un anziano che racconta la sua giovinezza non sta solo consegnando un ricordo: sta regalando un frammento del suo sguardo sul mondo, e quel frammento – se ascoltato con attenzione – può accendere domande inedite in chi lo riceve. Allo stesso modo, un giovane che condivide le sue incertezze non sta solo chiedendo consiglio: sta mostrando all’anziano un orizzonte che forse lui stesso aveva dimenticato.
Riconoscere questa unicità, dunque, non è solo un atto etico o affettivo, ma un gesto profondamente antropologico: è ammettere che ogni vita umana è una forma di sapere incarnato, un modo specifico di interpretare e restituire senso all’esistenza. E solo il dialogo — quello autentico, non funzionale — può dare accesso a questo patrimonio vivo, irripetibile, non trasmissibile per via tecnica. L’unicità diventa allora un dono circolare: più la riconosciamo nell’altro, più ci permette di scoprire la nostra. E forse, alla fine, è proprio questo il miracolo del dialogo tra generazioni: trasformare la solitudine di esistenze separate in un intreccio di storie che, senza annullarsi, si fanno specchio e sorgente l’una per l’altra.
Lo sguardo nuovo non è una tecnica né una strategia: è un modo di stare al mondo. È uno sguardo che non ha paura di fermarsi, di entrare in risonanza, di riconoscere valore là dove altri vedono solo limiti. E forse è proprio da questo sguardo che può rinascere una società più umana, capace di tenere insieme le generazioni non per necessità, ma per scelta.
Un ringraziamento particolare a Giulia Dapero che da anni si occupa di promuovere questo evento speciale.